Albert Speer (Mannheim 1905-Londra 1981) fu per molti “l’architetto del diavolo”, avendo servito Adolf Hitler sotto il Terzo Reich. Ogni libro su Speer, pertanto, si incardina inevitabilmente sui seguenti interrogativi: Speer fu nazista e antisemita? Fu consapevole della cosiddetta “soluzione finale”? Ebbe un ruolo nell’attentato ad Hitler di Von Stauffenberg? E, da ultimo, fu Albert Speer un grande artista? Naturalmente, quest’ultimo interrogativo è di un certo interesse esclusivamente per uno storico dell’arte. Proviamo a fornire delle risposte, in estrema sintesi e procedendo con ordine. Speer fu nazista? No. Speer non fu mai nazista, per un motivo molto semplice: essendo un tecnico “puro” – non un “artista”, per i motivi che vedremo nel seguito – non ebbe mai interesse per la politica. Si avvicinò al nazionalsocialismo – come molti altri tedeschi – unicamente perché affascinato dalla personalità del Fuhrer del quale si definì “forse l’unico amico”, ma, soprattutto, a causa delle miserabili condizioni in cui versava la Germania al tempo della Repubblica di Weimar, quando – va ricordato – una crisi economica senza precedenti, artatamente provocata dalle esose richieste dei trattati di Versailles, aveva messo in ginocchio il popolo tedesco. Fu soltanto con il cancellierato di Hitler che la Germania uscì dalla crisi, e i notevoli successi del governo nazionalsocialista guadagnarono al Fuhrer il favore della popolazione. Non si è mai capito perché certuni, come Ian Kershaw, abbiano parlato di “enigma del consenso”: chi ha fame, morde forse la mano che porge il cibo? Neppure un cane lo farebbe. Certo, Speer era ben conscio dell’antisemitismo insito nell’ideologia nazista, ma non aveva mai letto il Mein Kampf (1924) né tantomeno i voluminosi tomi di Alfred Rosenberg, ideologo ufficiale del partito. Ebbe una certa diffidenza nei confronti degli ebrei, ma, come è noto, tali sentimenti erano diffusi già da tempo non soltanto in Germania ma nell’Europa tutta, fin oltre gli Urali: basti citare soltanto l’Affair Dreyfuss in Francia ed il caso dei Protocolli di Sion diffusi nella Russia zarista. Tale diffidenza era perlopiù legata al mito della “pugnalata nella schiena” inferta all’esercito del Kaiser durante la Grande Guerra, sebbene fossero effettivamente pochi gli ebrei riconosciuti colpevoli di tradimento. Inoltre, il fatto che il movimento spartachista – cioè il partito comunista tedesco guidato da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, che si macchiò di violenze efferate durante la “settimana rossa” nel tentativo di rovesciare il legittimo governo socialdemocratico di Friedrich Ebert mediante un colpo di Stato sul modello leninista – avesse alcuni dirigenti ebrei (tra cui la stessa Luxemburg), fu una circostanza che contribuì ad alimentare un antisemitismo diffuso. Tutto ciò, è bene precisarlo, avvenne ben prima che Hitler assunse il potere, e indubbiamente non ha nulla a che vedere con Speer, che si iscrisse allo NSDAP tardivamente (la sua iscrizione data al 1° marzo 1931, tessera n. 474.481). Speer non fu, dunque, un “nazista della prima ora” né tantomeno un antisemita come Alfred Rosenberg o Julius Streicher. In merito alla consapevolezza della “soluzione finale”, è comprovato dai verbali dell’epoca che Speer non prese parte alla “Conferenza di Wannsee” (20 gennaio 1942) né ebbe mai alcuna diretta responsabilità nella gestione del sistema concentrazionario: sebbene fosse, dal 1942, un Ministro del Reich, l’organizzazione del partito e del governo nazista era “a compartimenti stagni”, pertanto è perfettamente plausibile che Speer ignorasse ciò che avveniva ad Auschwitz, a Treblinka o a Bergen-Belsen, in quanto la responsabilità dei campi di concentramento era di pertinenza esclusiva delle SS di Heinrich Himmler. Fu lo studioso israelita Erich Goldhagen (Roznow, Polonia 1930-2024), anni dopo, ad accusare Speer di aver mentito al processo di Norimberga. È bene ricordare che Goldhagen, sebbene fosse un sopravvissuto di Auschwitz, denunziò senza riserva alcuna anche i crimini dei sovietici - a differenza di altri storici - ed in particolare le persecuzioni antisemite sotto Stalin: nel denunziare i crimini nazisti, non assolveva ipso facto tutti gli altri criminali della storia, e ciò va detto per onestà intellettuale. Goldhagen era forse in buona fede quando accusò Speer, ma tali accuse non avevano un fondamento granitico: il fatto che Heinrich Himmler abbia menzionato Speer, per il suo ruolo di Capo dell’Organizzazione Todt, in un discorso abbastanza esplicito – sebbene scevro di dettagli tecnici – sulla “soluzione finale”, non inficia quanto detto innanzi; cioè, che la struttura “a compartimenti stagni” del potere nazista consentiva ad Hitler di tenere all’oscuro dei suoi piani riservati persino alti gerarchi del partito. David Irving arrivò addirittura a sostenere che il Fuhrer stesso fosse all’oscuro della soluzione finale: il fatto che Himmler avesse creato una struttura parallela all’interno dello NSDAP, con uomini di sua fiducia – una sorta di “governo ombra”, sebbene la definizione sia impropria – avrebbe dovuto comprovare siffatta tesi, che però non è dimostrata né plausibile. Speer ha sempre negato di averne avuta reale consapevolezza, al massimo fu sfiorato da qualche tremendo sospetto: d’altro canto, gli unici ebrei di cui era direttamente responsabile erano i forzati che servivano come manodopera per l’Organizzazione Todt che dirigeva, e che pertanto non erano destinati alle camere a gas. Tra l’altro, è perlomeno paradossale inorridire per l’uso di gas come lo Ziklon-B mentre si fa spallucce dinnanzi ai 5 milioni di morti ucraini, uccisi da Stalin per fame: una morte ben più lenta, al termine di un’agonia interminabile. E questo è solo uno dei tanti crimini compiuti in nome del comunismo sovietico. Indubbiamente, i lager nazisti hanno beneficiato delle luci di Hollywood. Ma, soprattutto, a Norimberga i complici degli assassini sovietici erano comodamente assisi sugli scranni della giuria e del giudice. È la stessa Autrice a rilevare che a Norimberga nel 1946 “la legge non era uguale per tutti. Gli Alleati non avevano alcuna intenzione di permettere che emergessero prove documentali dei loro misfatti. Quei documenti, ogni volta che un avvocato della difesa trovava il coraggio di richiederli, risultavano sempre irreperibili. E tra i giudici sedevano i sovietici, che avevano invaso la Polonia e la Finlandia e maltrattato le popolazioni civili nei paesi baltici, in Polonia, in Germania, e, ovviamente, nel loro paese con la stessa brutalità dei nazisti” [p. 799]. Da questo punto di vista, il Feldmaresciallo del Reich Hermann Goering (Rosenheim 1893-Norimberga 1946) a buon diritto negava la legittimità del tribunale imbastito da americani e sovietici. In merito all’attentato del 20 luglio 1944, Speer stesso ha sempre negato non soltanto di avervi preso parte, ma ha anche negato di essere a conoscenza della cospirazione ordita dai generali. Perché non credergli? Se avesse mentito su questo, sarebbe un non-senso logico, perché delle due l’una: o ammettiamo che Speer abbia detto la verità a Norimberga, oppure dobbiamo presumere che mentisse. Ma se mentiva per salvarsi la vita, perché negare il suo coinvolgimento in un attentato ad Hitler, che gli avrebbe senz’altro attirato le simpatie dei giudici? Da ultimo, Speer fu un grande architetto? In fin dei conti, quel che c’interessa è lo Speer architetto, non il politico. Ebbene, anche la risposta a questa domanda è NO. Egli fu un architetto di enorme successo, ma non fu mai un “artista” nel vero senso della parola: non era un Michelangelo Buonarroti, e nemmeno un Marcello Piacentini (l’architetto di Mussolini, che progettò le maggiori opere del Regime tra cui l’Eur di Roma). È lo stesso Speer ad ammettere i propri limiti: la sua vocazione giovanile era la matematica pura, studio dal quale fu dissuaso dal padre. Speer ebbe sicuramente un’intelligenza fuori del comune, e alcune geniali intuizioni: uno spiccato senso per la scenografia, che lo portò ad ideare le famose “cattedrali di luce”. Non a caso fu nominato ministro, a capo della “Organizzazione Todt”, proprio per le sue innate doti di eccezionale organizzatore. Speer era peraltro un disegnatore piuttosto mediocre, come ammette egli stesso. Il metodo di lavoro dello “Studio Speer” era sostanzialmente il seguente: Hitler forniva le indicazioni di massima, solitamente sotto forma di schizzi tracciati di sua mano; Speer formalizzava le idee del Fuhrer, stabilendo i rapporti dimensionali attraverso la redazione di uno schema preciso; i collaboratori di studio (Rudolf Wolters, Willie Schelkes, Hans Stephan) redigevano i progetti definitivi e gli esecutivi, peraltro occupandosi della realizzazione dei grandi plastici in gesso. Non è casuale la totale assenza di disegni autografi nelle pubblicazioni che parlano di Speer, a cominciare dalla sua stessa opera autobiografica (Memorie del Terzo Reich, Diari di Spandau) dove vengono presentate unicamente le foto dei plastici e delle opere realizzate: se un architetto che non ama mostrare i propri disegni, ciò costituisce decisamente un fatto significativo. Il libro di Gitta Sereny (Vienna 1921-Cambridge 2012), storica e giornalista britannica d’origine ungherese, è un contributo di capitale importanza per comprendere Albert Speer nel suo contesto storico, cioè in qualità di membro di primaria importanza dell’entourage del Fuhrer. Il ponderoso volume fornisce numerose prove testimoniali e documentali, a sostegno delle argomentazioni che abbiamo sovraesposto. Ma “l’enigma Speer” è davvero risolto?
Social
Contattaci
Indirizzo
Italia
Recensione. Gitta Sereny, Albert Speer. La sua battaglia con la verità, Adelphi, Milano 2025
Recensione. Gitta Sereny, Albert Speer. La sua battaglia con la verità, Adelphi, Milano 2025
2025-05-26 20:21
2025-05-26 20:21
Array() no author 84482
Recensioni, Albert Speer, Adolf Hitler, Gitta Sereny, Adelphi, Erich Goldhagen, Memorie del Terzo Reich, Hermann Goering, Rudolf Wolters, Diari di Spandau, Norimberga,
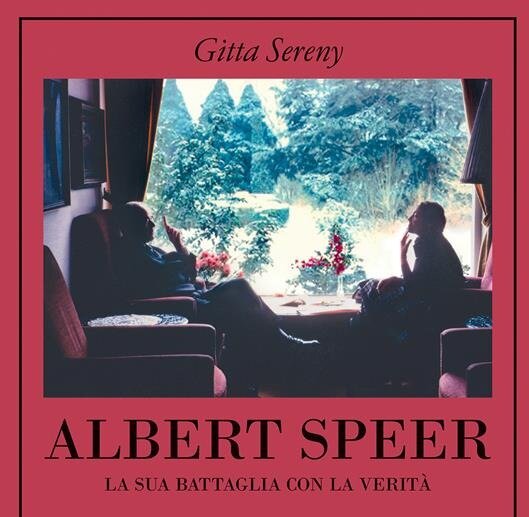
©
Social
Contattaci
Indirizzo
Italia
©