Il volume in parola ha molti pregi, è davvero una preziosa miniera d’informazioni. Bisogna però intendersi su quali informazioni vi si trovano, e quali si cercherebbero invano. È invalso ormai l’uso di intendere per “arte” la sola pittura, e perdipiù la sola pittura “colta” ossia oggetto di esposizioni e mostre prestigiose, meglio se di risonanza internazionale: non possiamo quindi accusare l’Autore di parzialità, visto che si conforma all’uso corrente. Vi si trovano pochi cenni, seppur significativi, all’architettura, in particolare al suo deus ex machina Marcello Piacentini. Il focus è sulla pittura presente alle mostre, oggetto del dibattito della critica: scarsi i riferimenti alla pittura murale, eccezion fatta per Mario Sironi e Achille Funi (nonché per Corrado Cagli, fervente fascista prima, fervente antifascista poi) e alla scultura monumentale, fatta salva l’opera di Arturo Martini.
È esclusa in toto l’arte “passatista”: niente affreschi di De Carolis, niente sculture di Arturo Dazzi o Pietro Canonica, nessun cenno per Duilio Cambellotti e via obliando; a maggior ragione, non vengono trattati artisti troppo “provinciali”, o per meglio dire meno celebri (e celebrati), come Mario Prayer, Sanzio Blasi, Mario Sabatelli o Armando Violi. È il dibattito sulle riviste, il vaniloquio della critica a prendere il sopravvento. Non possiamo però – lo ribadiamo – farne una colpa all’Autore, che anzi dimostra una vasta conoscenza delle esposizioni nel Ventennio, arrivando perfino a menzionare Julius Evola, il noto filosofo la cui attività pittorica – futurista e astrattista – viene sovente bistrattata dalla blasonata critica antifascista.
Un altro merito del libro – merito non di poco conto – è quello di prendere le distanze dalla “vulgata antifascista” del dopoguerra, che conferiva patenti postume di antifascismo a dei puri e semplici voltagabbana: critici come Argan e Bianchi Bandinelli (quest’ultimo addirittura fece da “cicerone” ad Hitler durante la sua visita a Roma), pittori come Cagli e Mafai – perfino Guttuso, artista capofila del PCI, la cui doppiezza ha ben poco da invidiare a quella di un politicante astuto come Togliatti, manutengolo di Stalin e nel contempo quinta colonna americana – ma l’elenco sarebbe troppo lungo. Sono “gli eroi di tutti i regimi”, come giustamente ebbe a definirli Nino Tripodi.
Fatta piazza pulita delle falsità della critica “militante”, l’Autore riporta la viva voce dei protagonisti di quegli anni: oltre alle numerose citazioni nel testo, vi è una interessante appendice documentaria in cui sono riportati testi integrali (non censurati) di articoli dell’epoca.
È oltremodo interessante l’articolo in cui Telesio Interlandi riporta caustiche critiche a Marinetti e a tutti i modernisti, la cui pseudo-arte è bollata come “bolscevizzante e giudaica”. In tempi di “antirazzismo” in cui, in particolar modo, l’antisemitismo – sia nella variante dell’antisionismo politico che dell’antigiudaismo cattolico – è “tabù”, il discorso di Interlandi può apparire superato, irrazionale e persino delirante. Ma, se provassimo a eliminare tutti gli aggettivi riferiti agli ebrei, ne verrebbe fuori un discorso estremamente lucido e coerente: sicché la polemica “antigiudaica” appare come un inutile orpello, in quanto superflua – oltreché, naturalmente, dannosa alla causa tradizionalista e antimoderna, col senno del poi. Non è certo prerogativa esclusiva degli ebrei, quella che - non soltanto da Hitler, ma anche da Papa Pio XI – veniva definita “arte degenerata”! Tanto per fare un esempio, Arrigo Minerbi – scultore prediletto del Vate – era ebreo: non soltanto lavorò per il Fascismo, ma operò con sentimento squisitamente classico, realista e figurativo. Interlandi erra nel porre l’equazione ebreo=astrattista, né tantomeno il bolscevico è di per sé “astrattista” – non perlomeno nel periodo stalinista, quando imperava il cosiddetto “realismo socialista”. E gli esempi potrebbero continuare. Al netto di tali considerazioni, le parole di Telesio Interlandi sono pienamente condivisibili: schietto buon senso, che smaschera decenni di imposture della sedicente “critica”.
Pur prescindendo dal retorico interrogativo “può l’arte fiorire sotto una dittatura?”, ciò che maggiormente contestiamo all’Autore è il riferimento alla “anemica pittura realista”. Non troviamo alcunché di “anemico” in artisti come Mario Prayer, Piero Annigoni, Gregorio Sciltian; per non parlare del vigore espressivo di scultori figurativi come Pietro Canonica, che non si lasciano fuorviare da futurismi ed espressionismi. Anzi, il ritorno alla figurazione è intrapreso da Balla e da altri “futuristi pentiti”. Non da ultimo, il tanto bistrattato “Premio Cremona” voluto da Farinacci (in concorrenza col Premio Bergamo di Bottai, nel testo chiamato “Bruno”) vide artisti valorosi, distanti dall’opportunista Guttuso che scimmiottava Picasso (gli artisti del premio Cremona sono stati rivalutati, in tempi recenti, anche da Vittorio Sgarbi). Ciò nondimeno, dobbiamo ribadirlo, il libro è pregevole e merita la lettura.
Social
Contattaci
Indirizzo
Italia
Recensione. F. BENZI, Arte in Italia tra le due guerre, Bollati Boringhieri, Torino 2013
Recensione. F. BENZI, Arte in Italia tra le due guerre, Bollati Boringhieri, Torino 2013
2024-11-12 18:08
2024-11-12 18:08
Array() no author 84482
Recensioni, Marcello Piacentini, Mario Sironi, Arturo Dazzi, Vittorio Sgarbi, Achille Funi, Arte in Italia tra le due guerre, Fabio Benzi, Premio Cremona, Pietro Canonica, Corrado Cagli,
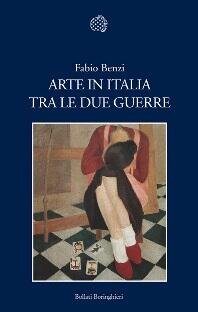
©
Social
Contattaci
Indirizzo
Italia
©